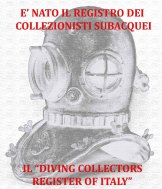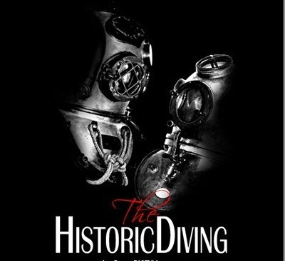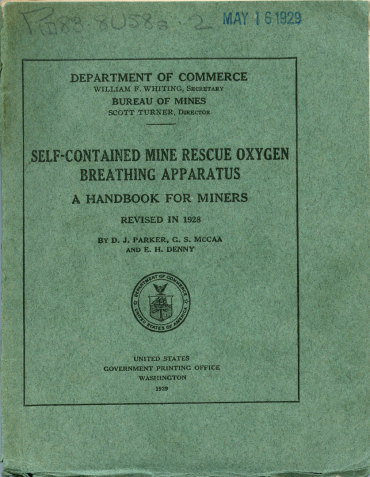La conquista delle profondità - 1^ parte
Lo scafandro da palombaro ha consentito l’accesso dell’uomo al mondo sottomarino ma le leggi fisiche avevano stabilito che usando aria per la respirazione, l’uomo non potesse varcare le porte dell’alta profondità, dovendosi fermare tra i quaranta e i cinquanta metri.
Ma l’uomo, si sa, per sua natura tende a essere incontentabile e curioso. Dopo ogni sfida vinta, trova subito le motivazioni per metterne in piedi un’altra. In fin dei conti è la storia del progresso umano.
Così è stato anche nel campo dell’esplorazione sottomarina. Si è dovuti passare attraverso il pagamento di un elevato tributo nell’arco dei primi settant’anni, con tanti palombari caduti preda della “malattia dei cassoni” (embolia gassosa) e della narcosi da azoto. Poi l’uomo ha cercato in tutti i modi di oltrepassare tali ostacoli, venendo prima a capo del problema embolia con le tabelle di Haldane nel 1907. Successivamente si è posto il quesito di come superare certe profondità al di là delle quali il palombaro perdeva di lucidità e quindi di capacità operativa. Era come se una certa ebbrezza, dovuta a un eccesso di bevande alcoliche, lo pervadesse fino a fargli commettere qualche sciocchezza.
Nel 1919 un incredibile inventore e innovatore, l’ingegner Elihu Thomson, ipotizzò che per prevenire i fenomeni narcotici dell’aria respirata sotto pressione bastasse sostituire l’azoto con un gas più leggero, vale a dire dal peso molecolare inferiore.
Non fu l’unico e a testimoniarlo c’è un interessante documento storico, un brevetto depositato il 15 agosto del 1919 da Charles John Cooke, un inglese residente a Washington.
Cooke deposita il brevetto di una miscela respiratoria per uso subacqueo. Le sue spiegazioni sono assolutamente sorprendenti e ci dicono che, già in quell’anno, c’era l’assoluta consapevolezza dei problemi legati alla respirazione di aria a elevate pressioni e l’identificazione precisa nell’azoto quale agente scatenante questi problemi.
Manuale americano datato 191 del “Bureau of Mines” sull’utilizzo degli apparati di ricircolo a circuito chiuso a ossigeno per il soccorso nelle miniere.
Nel suo brevetto, Cooke spiega dettagliatamente tutte le problematiche inerenti la respirazione di aria compressa e fornisce, come soluzione, alcune miscele alternative dove è sostituito l’azoto con un altro diluente. Le miscele dichiarate da Cooke sono tre: elio-ossigeno, argon-ossigeno e idrogeno-ossigeno. L’elio viene definito abbastanza inerte anche se da un punto di vista chimico, come diluente sarebbe preferibile l’idrogeno. Quest’ultimo, però, è pericoloso da gestire perché potenzialmente esplosivo quando miscelato con l’ossigeno.
In pratica Cooke, nel 1919, già spiega in modo dettagliato e chiaro quelle che poi saranno le soluzioni adottate in concreto dopo anni di sperimentazioni.
Tutto questo fermento sull’uso dell’elio derivava in parte dalla scoperta di grossi giacimenti di questo gas in Texas. L’elio era un gas relativamente giovane, essendo stato scoperto nel 1868 ma estratto solo a partire dal 1895 e inizialmente soltanto negli Stati Uniti. L’elio si poteva estrarre da minerali di uranio e torio attraverso un procedimento di decadimento radioattivo ma, più facilmente e in quantità maggiore, si poteva trovare anche in particolari giacimenti di gas naturali come quelli del Texas. L’unico problema dell’epoca era che non si trovava ancora un’applicazione pratica per questo gas.
L’ingegnere Eliuh Thomson
Quindi, il monopolio nella estrazione dell’elio e la ricerca di un suo possibile utilizzo furono le principali motivazioni che portarono gli americani a sperimentare per primi le miscele elio-ossigeno fin dal 1921, anno nell quale la Marina degli Stati Uniti, a seguito degli stimoli dello stesso Thompson e di un altro ricercatore, Behnke, si dichiarò interessata a una sperimentazione nel campo delle miscele respiratorie a base di elio. I primi esperimenti furono condotti nella stazione sperimentale del Bureau of Mines di Pittsburgh e iniziarono testando l’effetto della miscela sugli animali per poi continuare gli studi con soggetti umani. Si comprese, dalle prime evidenze, che si era imboccata una strada molto interessante.
In campo militare, la sperimentazione di miscele per l’alta profondità fu sospinta inizialmente dalla necessità di intervenire a quote sempre maggiori nell’opera di soccorso ai sommergibili affondati. Nel 1925 e nel 1927 l’U.S. Navy aveva perso, causa collisioni accidentali, due sottomarini, l’S-51 e l’S-4. Gli affondamenti dei sottomarini si risolvevano di solito con la perdita totale dell’equipaggio e questo destava grande emozione tra l’opinione pubblica, oltre che grande preoccupazione tra i sommergibilisti.
Il brevetto depositato da Charles John Cooke nel 1919 sull’uso di miscele sintetiche nella respirazione subacquea.
Qualche volta parte dell’equipaggio riusciva a sopravvivere alle prime fasi dell’affondamento rifugiandosi nei comparti stagni non invasi dall’acqua ma, di solito, soccombeva nelle ore successive a causa dell’enorme difficoltà delle manovre di salvataggio.
I palombari, quando era possibile, lavoravano sul sommergibile, ma spesso, causa la poca lucidità per l’aria respirata ad alta pressione, lo facevano con scarsissimi rendimenti.
Fu così che, per cercare una soluzione a questo problema, il Navy’s Bureau of Construction and Repair si mise al lavoro in sinergia con il Bureau of Mines (con notevole esperienza nel campo delle apparecchiature a circuito chiuso a ossigeno per il soccorso nelle miniere e soprattutto proprietario dei maggiori giacimenti di elio).
Nel 1924 si cominciò la sperimentazione con immersioni “a secco” in camera iperbarica, arrivando a profondità intorno ai 50 metri.
I primi risultati confermarono che il palombaro poteva raggiungere profondità elevate senza manifestare fenomeni di alterazione psicofisica. Si cominciavano a socchiudere delle porte.